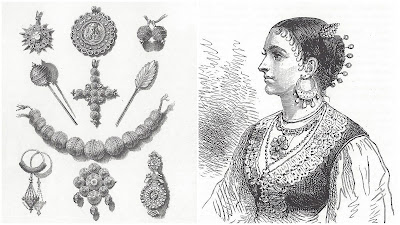Dopo la prima guerra mondiale la città divenne un’exclave italiana, capoluogo della Provincia di Zara, circondata dalla Dalmazia jugoslava.
 |
| Lo stemma e l'estensione della exclave italiana istituita dal Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, firmato mentre le truppe irregolari di D'Annunzio spadroneggiavano a Fiume. |
 |
| Zara era molto conosciuta per i suoi liquori aromatizzati con la locale ci- liegia della varietà marasca. Nella foto si vede lo stabilimento del mar- chio leader, la "Luxardo", che acquistò fama internazionale grazie al suo Maraschino e, durante la impresa di Fiume, per il suo Sangue Morlacco. |
👉Alla vigilia della prima guerra mondiale con il Patto di Londra fu promessa all’Italia, in caso di vittoria, poco più della metà della Dalmazia, inclusa Zara. Ma a conflitto terminato le nuove pretese
👉Il regime fiscale privilegiato spiega perchè a Zara durante il suo periodo